Ciao pirati,
da settimana scorsa siamo di più! Grazie alla collaborazione con Mirabilia - il Podcast delle storie straordinarie la nostra ciurma è cresciuta e abbiamo qualche nuovo pirata a bordo. Benvenuti!
Se non avete ancora ascoltato la puntata, vi consiglio di farlo: parliamo dell’etimologia della parola “peccato” e della pratica funeraria di consumare tramite un pasto i peccati di un defunto per “assolverlo” dalle sue malefatte.
Proprio perché abbiamo molti nuovi occhi nella nostra ciurma, ho pensato fosse interessante per tutti fare una puntata su una parola davvero difficile, una di quelle che raramente si fanno usare in una conversazione tra amici1.
Oggi parliamo di metanoia.
Iniziamo con lo specificare l’accento: siamo sicuramente tentati di pronunciare questa parola come “metanòia”2, ma questo ci trarrebbe in inganno: penseremmo che si tratta di una noia particolare, una noia di secondo livello, una noia per interposta noia, un modo consapevole di annoiarsi, e via discorrendo.
In realtà l’accento corretto è “metànoia” e gli sbadigli c’entrano molto poco: si tratta infatti dell’unione di due parole greche, il sostantivo noéo (νοέω), pensare, e la preposizione meta-, (μετα-) che, quando è prefisso come in questo caso, indica un cambiamento.
La metanoia è quindi un cambiamento di pensiero, ma il termine non va usato con leggerezza: non è avere voglia di hamburger e improvvisamente decidere che si preferisce ordinare una pizza. La metanoia è un cambiamento profondo, un mutamento radicale del proprio pensiero e della propria mentalità. Il suo uso più comune in italiano è di ambito religioso - si utilizza per indicare la conversione di un fedele - ma non sarebbe scorretto chiamare “metànoia” un cambiamento di pensiero filosofico, morale o politico.
Metanoia è un termine anche utilizzato in linguistica: è una figura retorica che indica il ritrattare un'affermazione per poi poi dirla nuovamente in un modo migliore; è una figura simile a una correzione.
“Mi hai detto che avresti portato tu la pizza. Me l’hai fatto capire”
Prima affermo che tu mi hai detto - chiaramente, inequivocabilmente - che avresti portato la pizza; poi mi rendo conto che forse non è andata proprio così, e mi correggo: me l’hai solo fatto capire.3
In questo secondo caso la metanoia non è un cambiamento di pensiero poi così profondo, anzi: sembrerebbe avere un significato più simile al semplice “cambiare idea”.
Quindi perché la metanoia in italiano oggi, figura retorica a parte, ha un’accezione così pesante? Originariamente in greco il verbo metanoéo (μετανοέω) poteva significare:
cambiare idea
cambiare scopo
pentirsi
Era una parola che, quindi, a seconda del contesto, poteva contenere tutti questi significati; ed è il termine che i vangeli del nuovo testamento della Bibbia cristiana scelgono di usare per descrivere il processo di conversione al cristianesimo: un cambiamento di idee e di scopo della propria vita che contiene un pentimento. La metanoia diventa la conversione religiosa e a noi il termine giunge con un peso molto più forte che il semplice “cambiare idea”.
Ai linguisti però non interessa e ci chiamano così la loro figura retorica.
A meno che non siate assidui lettori della burrasca, ovviamente.
Su questo ci sarebbero moltissime cose da dire: statisticamente le parole italiane sono nella stragrande maggioranza tronche, piane o sdrucciole, ovvero hanno l’accento sull’ultima (caf-fè), la penultima (pàn-na) o la terzultima sillaba (zùc-che-ro). Quando leggiamo per la prima volta una parola di cui non conosciamo l’accento, tendiamo istintivamente a leggerla come se fosse tronca, piana o sdrucciola, perché per noi è semplicemente più facile che sia così, nonostante in italiano esistano delle parole bisdrucciole, ovvero con accenti sulla quartultima - sono soprattutto verbi flessi, come à-bi-ta-no, è-di-ta-no, òc-cu-pa-no, et cetera.
Ricordo per esempio che quando ero in convitto all’università studiavo spesso accanto a una studentessa di finlandese che, mentre io leggevo un manuale sulla filologia dei testi a stampa, leggeva il Kalevala, il poema epico più importante della Finlandia, e mi raccontava di come in tanti sbagliassero a dirne il titolo: lo pronunciavano Kalèvala, e non il corretto e bisdrucciolo Kàlevala. Qui, con Google Translate potete sentire la corretta pronuncia in finlandese se cliccate sul simbolo dell’alto parlante; e se cliccate sulla pronuncia italiana potete ridere del tizio che dice Kalevàla.
Ma torniamo a metànoia: l’accento corretto si trova sulla terzultima (me-tà-no-ia), quindi è una parola sdrucciola e non dovrebbe essere così difficile da concepire per il nostro cervello; perché quindi ci viene da chiamarlo metanòia?
La risposta più ovvia è che ci sembra una parola composta dal prefisso “meta-“ e dalla più comune parola “nòia” e perciò le attribuiamo questo accento; probabilmente la vera risposta è proprio questa ma io mi sono fatta un viaggione che ora vi devo sottoporre.
Vi ricordate quando abbiamo parlato della storia della lettera J? Abbiamo parlato di occasioni in cui la lettera I, per la posizione in cui si trova all’interno della parola, assume il ruolo di semiconsonante e, storicamente, è stata scritta con una J (es: jeri, jato ma anche pjadina); ora, ci sarebbero paragrafi e paragrafi da dedicare al tema dei dittonghi, delle semiconsonanti e delle semivocali, ma ci basti sapere che in questa sede la I è semiconsonante, e la sua traslitterazione fonetica è proprio /'nɔja/. È anche per questo che la sillabazione di “noia” è “no-ja”, perché “oia” non è un trittongo ma la I funge da consonante, creando le due sillabe.
Ora, non è possibile che il nostro cervello veda quella I semiconsonante e decida che è una cosa troppo strana e importante per essere solo un pezzetto di una sillaba? Possibile che guardiamo “metanoia” e decidiamo nella nostra testa che la sillabazione corretta è “me-ta-no-j-a”, rendendo la pronuncia “me-tà-no-j-a” un obbrobrio bisdrucciolo e facendoci leggere il più naturale e sdrucciolo “me-ta-nò-j-a”?
Come vi dicevo, probabilmente non è così e la mia teoria regge molto poco, proprio perché in questa posizione la I è semiconsonantica e le consonanti da sole non possono mai essere una sillaba a se stante. Però è bello blaterare con voi, e magari a qualcun altro possono venire delle idee geniali su come risolvere questo mistero.
Lo ammetto: non è la figura retorica più utile o poetica del mondo. Però esiste, e si chiama così.


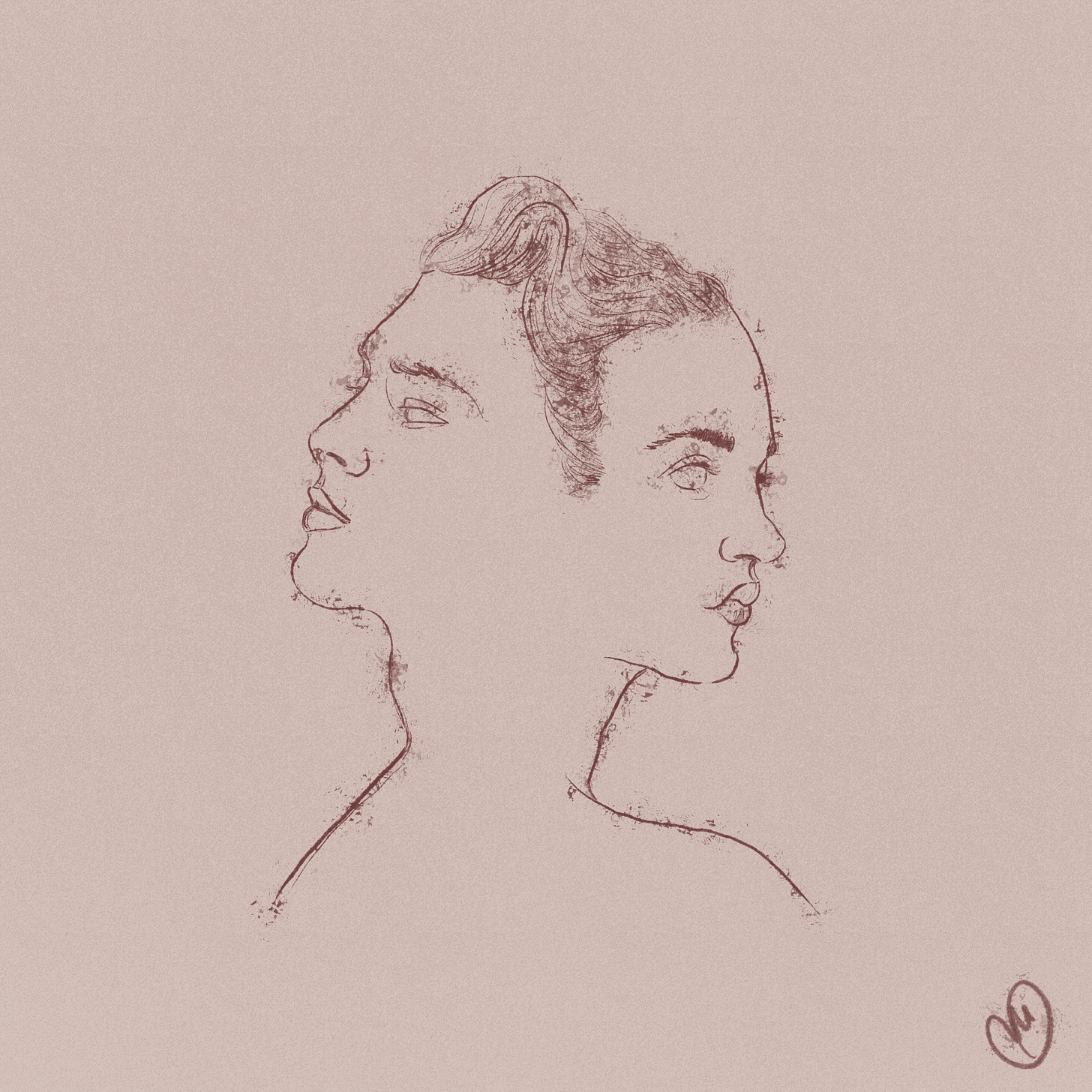
Un ben arrivati ai nuovi pirati!
Ho imparato un sacco di cose! Grazie